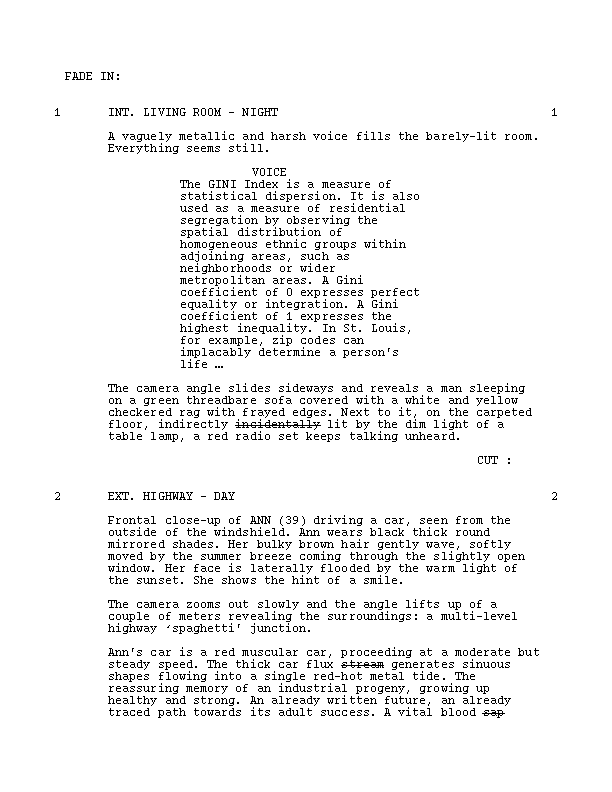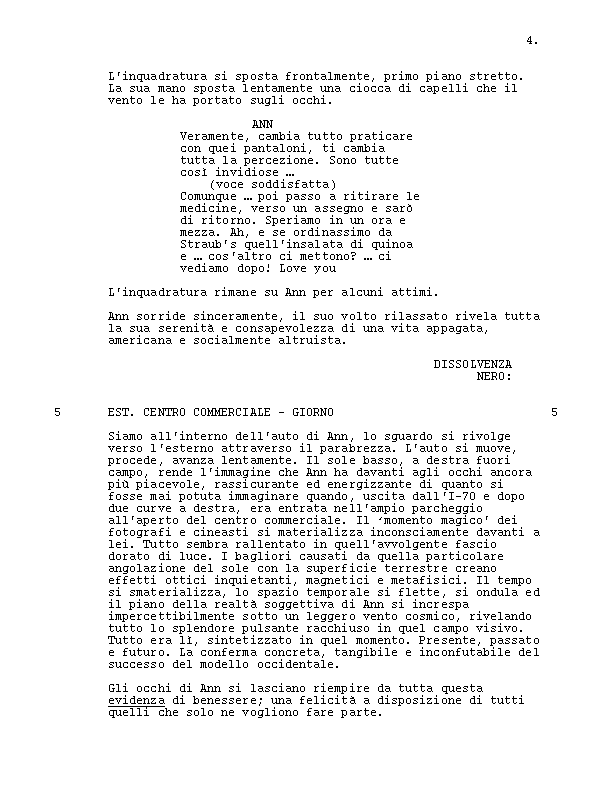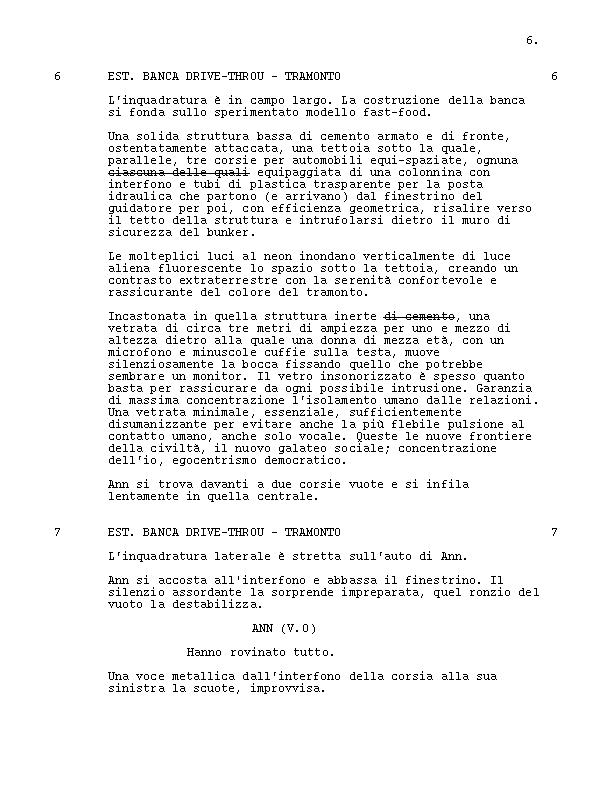Tag: Text
Travellers
Travellers
Scenes from Kulusuk airport
(Italian at the bottom)

Kulusuk, July 22nd 2016
The profanation of innocence. Dressed alike human beings walk down the boarding ladder, dazed, protected by digital glasses. The TV, the gate in which reality resides and lives, the house screen materialized here, moved through tablet screens or digital cameras.
Anything, as long as you don’t use your eyes.
The screen that reassures and protects from the unknown and the wild, the passepartout to an alibi for an invasion (without any fault), to a world made of different human beings.

The certainty (at least two years on-site) that the far earth will always be impressed through layers of silicon that manifest themselves as small spots, or rather through tiny, digital squares that create reality; they don’t replace it: on the contrary, they become IT.
Mind, brain, human tools: they’re not useful anymore. Now you don’t have to face anything without the help of protection and emotional filters anymore.

You have to take note, NOT live the moment; you have to leave a trace, have to have been here or there — this is essential. A supermarket of prêt-à-porter, disposable adventures that rise and fall like fashion seasons: evanescent and dangerously temporary.


All of this, these thoughts and maybe something else, all of this came to my mind in a split second. Everything that I’ve seen scares me. And maybe, even more so the future developments that are inevitable, by now. Human pollution, the clear perception of indifference through which these bodies get airborne (often without their critical, sensorial knowledge) and face these ‘holy’, pure, innocent, solitary, placid lands. Lands that demand silence, patience, whispers, and not shouts. Thoughts, rather than words.

It’s inevitable, and the last chapter of Aldous Huxley’s Brave New World appears before my eyes with the striking force of a thunderbolt. The concept of helicopters packed with curious ALPHA citizens, conformed to preordained life and thoughts, citizens who want to see John “the Savage”, who’s been taken away from the Indian reservation as an experiment of “civilization”; John, who only claimed the right to poetry, kindness, sin, true danger… the right to “be unhappy”, according to Controller Mustapha.
“I hate civilization,” he said before taking shelter in a lighthouse “… it poisoned me.”
I wonder what took — and keeps taking — here, to the end of the world, in Eastern Greenland, shapeless, mononucleical groups of Chinese people, if not an awkward attempt of westernization (a self/new cultural revolution). Something that doesn’t belong to them, but that they do because they saw western people do it, hence they repeat it (aseptically, uncritically).


A new souvenir, an X on the world map — digital —, the strength of a post, a selfie on Facebook. Everything lasts a moment, those few, necessary seconds you need to look at a picture, a like, and then the oblivion or vague remembrances of something that were maybe a pleasant memory.
Or, perhaps, the revenge of the subconscious toward the other half of humanity (“for the cultural revolution wasn’t that bad! It made us free and threw us into the world”), a sense of inferiority on a unconscious level (“See, this revolution didn’t destroy us”) that must be proved wrong.
Women, in their little walking hats that seem to have come out of some mall and are coordinated with hi-tech clothes normally proposed by shop assistants for 8000–meter heights (but here, in summer, you usually walk around wearing light pile, jeans and shoes (I agree only if they’re trekking shoes), they become animated and hysterical all of a sudden, after finding out about the most important proof of belonging. They stand in line in order to get the Greenland stamp on their passport: mass neuronal hysteria while they board, for that stamp will cause so much envy once back home, during their suppers accompanied by projections on wide plasma screens — it would be even better if they were curved.
I must confess: for one moment, I’ve wanted that stamp on my passport as well, maybe because I was drawn to that magnetizing mass energy, like a magnetic force that takes you to comradeship and conformation. I’ve thought about it, I’ve craved it for some seconds; then I’ve recovered and quickly left the gate in order to stop my regrets. If you want something to exist, you have to prove it. It mustn’t exist for you, but for the others.

Icebergs, like migrants, like ships, like satellites nobody can guide to the unknown, deep space anymore; they venture into the open sea, into the black, dangerous waters, alone; they slowly melt, without screaming, resigned, with a whisper, without bothering, even before catching sight of the Icelandic shoreline.

Surrounded by indifference, toward an eternal oblivion.
Earth to earth, water to water.
Aakkunnaarpoq – (v) not to melt anymore, not to bleed anymore.

Kulusuk, 22 luglio 2016
Profanazione dell’innocenza. Esseri umani vestiti tutti uguali scendono imbambolati la scaletta dell’aereo, protetti da occhi digitali. La TV, il gate nel quale risiede e vive la realtà, lo schermo di casa qui materializzato, traslato attraverso schermi di tablet o camere digitali.
Tutto, basta non usare i propri occhi.
Lo schermo che rassicura e protegge dall’ignoto e dal selvaggio, il passepartout a un alibi per un’invasione (senza colpa), a un mondo di umani diversi.
La garanzia (almeno due anni on-site) di avere impressa per sempre la terra lontana attraverso strati di silicio che si manifestano in puntini, anzi minuscoli quadratini digitali che creano la realtà, non la sostituiscono ma diventano essi stessi LA realtà.
Non servono più la mente, il cervello, gli utensili umanistici. Ora non occorre affrontare più nulla sprovvisti di protezione e filtri emozionali.
Occorre registrare, NON vivere il momento. Bisogna, si rivela essenziale, lasciare una traccia (di essere stati qua o là). Un supermarket dell’avventura prêt-à-porter usa e getta, che fluttua come le stagioni di moda, evanescenti e pericolosamente transitorie.
Tutto ciò – questi pensieri e forse altro – è passato nella mia mente in una frazione di secondo. Tutto ciò che ho visto mi spaventa. E forse ancor di più gli sviluppi futuri, ormai inevitabili. L’inquinamento umano, la chiara percezione dell’indifferenza con cui questi corpi vengono aviotrasportati (spesso a loro critica insaputa sensoriale) e affrontano queste terre “sacre”, pure, innocenti, solitarie e pacate. Terre che esigono silenzio, pazienza, sussurri e non urla, pensieri più che parole.È inevitabile, e con la forza d’urto di un fulmine mi si materializza davanti agli occhi il capitolo finale de Il mondo nuovo di Aldous Huxley. L’immagine di elicotteri stipati di curiosi cittadini ALFA, omologati in una vita e pensieri preordinati, che vogliono vedere John “il selvaggio”, prelevato dalla riserva indiana per un esperimento di “civilizzazione”; John, che reclamava solamente il diritto alla poesia, alla bontà, al peccato, al pericolo vero… il diritto «di essere infelice» secondo il “controllore” Mustafa.
«Odio la civiltà» – disse prima di rifugiarsi in un faro – «… mi ha avvelenato».
Mi chiedo cosa può aver portato, e sempre più portare, gruppi informi mononucleici di cinesi qui, alla fine del mondo, nella Groenlandia dell’est, se non un goffo tentativo di processo di occidentalizzazione (un’auto/nuova rivoluzione culturale). Fare qualcosa che probabilmente non appartiene loro, ma che hanno visto fare all’occidente e quindi da ripetere (asetticamente, acriticamente).
Un nuovo souvenir, una X sul mappamondo – digitale – la forza di un post, di un selfie su Facebook. Tutto dura un attimo, quei pochi secondi necessari a guardare una fotografia, un like, e poi l’oblio o vaghe memorie di qualcosa che forse era ricordo piacevole.
O forse una rivincita del subconscio nei confronti dell’altra metà dell’umanità («che la rivoluzione culturale non è stata poi così male! Ci ha resi liberi e proiettati nel mondo»), un senso di inferiorità diffusa a livello inconscio («vedete, la rivoluzione non ci ha distrutto») che bisogna dimostrare errata.
Le donne, con cappellini da passeggio da centro commerciale abbinati ad abbigliamenti hi-tech normalmente proposti dai commessi per cime di 8.000 metri (ma qui d’estate si gira con pile leggero, jeans e scarpe – quelle le concedo da trekking) si animano improvvisamente, isteriche, dopo aver scoperto la più importante delle prove di appartenenza. Fanno la fila per avere il timbro della Groenlandia sul passaporto. Isteria neuronale di massa durante l’imbarco, quanta invidia potrà suscitare un timbro al ritorno a casa, durante le cene con proiezioni su maxi schermi al plasma – meglio se ricurvi.
Lo ammetto, il timbro sul passaporto l’ho voluto anch’io per un momento, forse attirato da quella calamitante energia di massa, come una forza magnetica che ti porta al cameratismo e alla conformazione. L’ho pensato, l’ho desiderato per alcuni secondi, poi, ripresomi, sono uscito dal gate velocemente per non avere più rimpianti. Affinché qualcosa esista, occorre una prova da mostrare. Non deve esistere per te, ma per gli altri.
Iceberg, come migranti, come navi, come satelliti lasciati senza più guida all’ignoto spazio profondo, si avventurano solitari al largo nelle acque nere e insidiose; si sciolgono lentamente, senza urlare, rassegnati, con un sussurro, senza disturbare, prima ancora della vista della costa islandese.
Tra l’indifferenza, verso un oblio eterno.
Terra alla terra, acqua all’acqua.
Aakkunnaarpoq – (v) not to melt anymore, not to bleed anymore.
Void
Void
(Italian at the bottom)

The question came all of a sudden. At last.
After an endless, brief pause, when you’re about to treat yourself to a systemic, neural decompression, in that moment of cerebral darkness that precedes awareness, there, a girl worked up her courage and, in a trembling, clearly embarrassed voice — perhaps because of my presence or her fear of a stupid question — she ASKED.
My legs got shaky, and I felt the urge to sit down — maybe due to the imminence of the answer I could no longer postpone or the fact that, at last, I should have “faced myself” thanks to another person and solved this private matter once and for all.
I wanted to start by taking the time that such a stupid question required, comfortably and relaxed. A long, dense, deep breath and a few seconds to seek mental clarity — which never came.
“How do you photograph nothingness?” she asked.



I’d been spending years trying to get ready for that question, but then I always ended up getting caught in other thoughts owing to my mental laziness and my hidden, dark, personal reasons.
But when this question periodically popped up on my mind, I used to try to understand why I unconsciously avoided it — quickly, automatically; however, I always had nothing more than weak, unbearable answers.
This “nothingness” inevitably dragged me to metaphysical considerations about void, solitude, and silence; to that thin border line between reality and hanging/mystery, to dreadful, Nitzschean considerations about the intolerance of “the vision of life”.
And what if finding out Something were more dreadful than Nothingness?

I could have started with a Lacanian reflection on the “Thing”, that primitive, constitutive nucleus of the Ego that sounds unreachable and lost to us. The Thing that takes the shape of a central void, a hole. Something alienated, something “I cannot know even though it’s inside of me”, like something that always hangs between a hypothetical “inside” and a hypothetical “outside”. I could have philosophized about Art as the organization of the void, as the edging of the central void of the Thing, which is unrepresentable by definition — according to Lacan. In short, it’s about inserting absence in a form. The form of nothingness, indeed.
In art history, different concepts such as God, Nature, Infinity, Language, Void, Space, and Time, as Kounellis pointed out, have the same function, which is to build a bridge between reality and the intrinsic mystery of things.

I could have spoken about this… But I didn’t.
“Why do you want to know?” I asked. “I think nothing can be photographed per se, least of all the void, silence, or solitude. Let’s rather wonder how it manifests itself in us and around us. This can be photographed.”
“The void” I continued “with its clear, disarming awareness of ‘impossibility’ it carries around. DeLillo and Easton Ellis tell us about the void, about silence and nothingness through a human society by now collapsed and destined for moral — and probably physical — extinction. After all, as DeLillo states, time — in the age of global disaster — is told only by money, and people’s life and death are compared only to rats’.
“There are dead stars that still shine because their light is trapped in time. Where do I stand in this light, which does not strictly exist?”
D. DeLillo – Cosmopolis
“Turn up the TV, no one listening will suspect. Even your mother won’t detect it, so your father won’t know. They think that I’ve got no respect but Everything is less than zero.”
B. Easton Ellis – Less Than Zero
I continued… “Or silence, for example. Michelangelo Antonioni portrayed silence as a necessary place for moving from the invisible to the visible; a moment of unavoidable hanging, necessary for the incubation of the image, an emotional, space-time fracture of the brutal, existential reality.”

“Today the dialogues of a film broadcast on TV came into the living room: ‘If I were you, Jim, I wouldn’t do it.”
After this sentence, I heard the howling of a dog; long, sincere, perfect in its parable that ended in the air as in a great sorrow. Then I thought I heard a place, but it was my silence, and I was happy.
The park is full of silence made of noises. If you press your ear to a tree and listen, you’ll hear a noise eventually. Maybe it depends on us, but I like thinking it comes from the tree. That silence was broken by an alien noise disturbing the sonorous landscape around me. I didn’t want to hear it, I closed the window, but it persisted. I thought I was going out of my mind. I wouldn’t hear useless sounds, I would like to select them during the day, and the same goes for voices, words. There are so many words I wouldn’t listen to, but you can’t escape, you must resign yourself, just how you resign to the waves of the sea when you float on them.”
“Will you let me hear it again?”
La Notte – M. Antonioni

… silence
Recommended inspirations:
J. Lacan – Seminar. Book VII: The Ethics of Psychoanalysis
D. DeLillo – Cosmopolis
M. Antonioni – Incommunicability Trilogy / The Adventure, The Night, The Eclipse
G. Reggio – Koyaanisqatsi
B. Easton Ellis – Less Than Zero
F. Ruina – Lacan e l’estetica del vuoto (Lacan and the Aesthetics of the Void)
La domanda arrivò all’improvviso. Finalmente.
Dopo una pausa interminabile di alcuni secondi, quando si è lì lì per dismettere gli spettatori e concedersi una decompressione neuronale sistemica, in quel momento di buio cerebrale che precede la consapevolezza, ecco, una ragazza si fece coraggio e con voce tremula, evidentemente imbarazzata non so se per la mia presenza o per la paura di una domanda stupida, CHIESE.
—————-
Le gambe si fecero molli e la necessità di sedermi impellente. Ancora non so se per l’imminenza della risposta ora non più procrastinabile o perché finalmente avrei dovuto “affrontarmi” per intercessa persona e risolvere questa faccenda privata una volta per tutte.
Per iniziare volevo farlo comodamente, rilassato, prendendomi il tempo che una tale stupida domanda richiedeva. Un lungo, denso, profondo respiro e qualche secondo per cercare una chiarezza mentale, che mai arrivò.
“Come si fotografa il nulla?” – mi chiese.
—————-
Avevo cercato di prepararmi a quella domanda per anni. Ma poi, come sempre, la mia pigrizia mentale e le mie recondite buie motivazioni personali erano sempre riuscite a distrarre e impegnare la mia mente in altri pensieri.
Quando questa domanda mi riappariva alla mente però, ciclicamente, cercavo di capire perché inconsciamente la sfuggissi così velocemente e automaticamente; ma sempre avevo risposte deboli ed insostenibili.
Il “nulla” mi trascinava inevitabilmente in considerazioni metafisiche di vuoto, solitudine e silenzio; verso quella sottile linea di confine tra realtà e sospensione/mistero, in temibili considerazioni nicciane sull’intollerabilità della “vista della vita”.
E se la scoperta del Qualcosa fosse più terribile del Nulla?
Avrei potuto iniziare una riflessione Lacaniana sulla “Cosa”, quel nucleo originario e costitutivo dell’Io che risulta per noi inaccessibile, perduto. La Cosa che assume le sembianze di un vuoto centrale, di un buco. Qualcosa di alienato, di “estraneo a me pur stando dentro di me”, come ciò che resta sempre in bilico tra un ipotetico “dentro” ed un ipotetico “fuori”. Avrei potuto filosofeggiare sul concetto di Arte come organizzazione del vuoto, come bordatura del vuoto centrale della Cosa, per definizione non rappresentabile (secondo Lacan). Cioè, in sintesi, inserire l’assenza in una forma. Del nulla appunto.
Nella storia dell’arte concetti differenti, quali ad esempio Dio, la Natura, l’Infinito, il Linguaggio, il Vuoto, lo Spazio e il Tempo, come ha sottolineato Kounellis, hanno tutti la stessa funzione: creare un ponte tra il reale e il mistero intrinseco alle cose.
Avrei potuto parlarle di questo … ma non lo feci.
—————-
“Ma perchè lo vuoi sapere?” – le chiesi – “Credo che non si possa fotografare il nulla in sé, tantomeno il vuoto, il silenzio o la solitudine. Piuttosto chiediamoci come si manifesta in noi e attorno a noi. E questo si che si può fotografare.”
“Il vuoto” continuai, “con la sua chiara e disarmante consapevolezza di “impossibilità” che si porta appresso. Delillo e Easton Ellis ci raccontano del vuoto, del silenzio e del nulla attraverso una società umana ormai collassata e destinata all’estinzione morale e, probabilmente, fisica. D’altronde il tempo – nell’era del disastro globale – è narrato, come dice DeLillo, solo dal denaro, e la vita e la morte degli uomini è equiparata solo a quella di topi di fogna.”
«Ci sono stelle morte che brillano ancora perché la loro luce è intrappolata nel tempo. Dove mi trovo io in questa luce, che a rigor di termini non esiste?».
– Don DeLillo “Cosmopolis” –
«Accendi la TV, nessuno di quelli che ascoltano sospetterà. Anche tua madre non se ne accorgerà, così tuo padre non lo saprà. Pensano che non abbia rispetto ma Tutto è meno di zero»
– Brett Easton Ellis, “Meno di zero” –
Continuai … “Oppure il silenzio, ad esempio. Michelangelo Antonioni rappresentava il silenzio come luogo necessario per il passaggio dall’invisibile al visibile, un momento di sospensione inevitabile e necessario per l’incubazione dell’immagine, una frattura emotiva spazio-temporale della cruda realtà esistenziale.”
“Dal salone oggi venivano i dialoghi di un film trasmesso alla televisione: ‘se fossi in te, Jim, non lo farei.’
Dopo questa frase, c’è stato il guaito di un cane; lungo, sincero, perfetto nella sua parabola che si chiudeva nell’aria come, in un grande dolore. Poi mi parve di sentire un aereo, invece era il mio silenzio, e io ne ero molto contenta.
Il parco è pieno di silenzio fatto di rumori. Se metti un orecchio contro la corteccia di un albero e rimani così per un po’, alla fine senti un rumore. Forse dipende da noi, ma io preferisco pensare che sia l’albero. In quel silenzio ci sono stati dei colpi strani che disturbavano il paesaggio sonoro intorno a me. Io non volevo dirlo, ho chiuso la finestra ma quelli continuavano, mi sembrava di impazzire.
Io non vorrei udire suoni inutili, vorrei poterli scegliere durante la giornata, così le voci, le parole. Quante parole non vorrei ascoltare, ma non puoi sottrarti, non puoi fare altro che subirle, come subisci le onde del mare quando ti distendi a fare il morto.”
“Me lo fai risentire?”
– “La Notte”, Michelangelo Antonioni 1964 –
… Il silenzio.
Ispirazioni consigliate:
J. Lacan – Il seminario. Libro VII: L’etica della psicoanalisi
D. DeLillo – Cosmopolis
M. Antonioni – Trilogia dell’incomunicabilità / L’avventura, La Notte, L’eclissi
G. Reggio – Koyaanisqatsi
B. Easton Ellis – Meno di zero
F. Ruina – Lacan e l’estetica del vuoto
Naatsiiat
Naatsiiat
(Italian at the bottom)

Barco, Italy – December 01, 2016
Last night – it was nearly midnight – I was driving among the hills of Reggio Emilia, where I’m currently learning sculpture, for it’s been a while – a couple of years, I guess – since I’ve felt a compelling, physical urge (and mental, too, although one drags the other) to use my hands, get them dirty, touch the matter, feel that I’m alive, create something that will survive an unexpected blackout or technological obsolescence. Something that goes beyond pixels.
The more I look at myself, the more I realize I’m going backwards, as if I were running away from the evolution of society, which I understand less and less, and from whose interferences, I’ve realized, I often get influenced; therefore, I end up going backwards from a physical point of view. More and more. If I broke away from myself and could watch my habits, behaviors, spiritual and unconscious leanings, well, I would definitely see somebody who’s pulling back and hiding in the mountains: not the popular, traveled, touristic mountains, but the woods, the tall peaks, the rocky gulches in Casanova, where there used to be a convent and where the “Lion” lives alone today. I wander through these places, seeking loneliness to save me, just like some clean air beyond a blanket of dirty fog in the Po valley, as if it were the only way to defend myself from the white noise of human society.
Last night I was slowly driving downhill, the air was freezing, the wind was light – although it could easily cut you in two -, it woke you up from the mental numbness gathered during everyday life. I was driving slowly; I left the car window half-open so that I could take benefit from that view and that weather that framed my fantasy and dreams nearly perfectly (at least that’s how I looked at it), as well as my utopias, the same ones I’ve run after and that now make me smile and get me a little pissed off…
I drove downhill and smiled, breathing slowly and deeply, relaxed, since I already knew that I wouldn’t get enough, so I tried to catch – and steal – all that could be caught that night.
I was driving slowly, peacefully, taken with my thoughts, when I suddenly saw an animal on the leaning edge of the road, behind a bend. My brain immediately elaborated the vision of a roe deer, for it’s so common to see them around there at night. It lasted less than one second; soon after, I realized the animal that was standing in front of me was a wolf. It was the first time in my life. I didn’t move, but not because I was afraid: on the contrary, I was in the middle of an emotional storm; that kind of heat that comes unexpected, all of a sudden. I slowed down and stopped the car. The wolf was big, at least that’s what my emotions showed me; but no it was really big. I looked at it and felt a little thrill of fear when it turned towards me, got self-confidently close to my car and passed me by. I stood still for an indefinite period of time, perhaps just a few long seconds, and what I meant to steal that night, that greediness of emotions and impressions, well, I brought it away with me.
Naatsiiat is a Greenlander word that literally means “something one waits so long for, so that it grows”, but it also means “potato”.
Do you understand that, can you gather its destructive strength? Such a brand new perspective, this relationship between life and Greenlanders. Which destroys our Western certainties.
Time, a rhythm that is not imposed, the act of accepting and losing yourself in the natural will. Accepting a future perspective that doesn’t last more than a few days, if you’re lucky and it’s summer, for in winter the abandon is complete and everyday life is set by the will of wind, ice and snow.
This is what I call inspiration. For my photography.
Aputsiaq (“snowflake”)


Barco, Italia – 1 December 2016
La scorsa notte, era quasi mezzanotte, stavo scendendo dalle colline reggiane dove sto imparando a scolpire, perché da un po’ di tempo, che sono poi forse un paio d’anni, sento l’impellente necessità fisica (e mentale – ma una tira dietro l’altra) di usare le mani, sporcarle, toccare materia, sentire di essere vivo, creare qualcosa che sopravviva a un improvviso blackout o all’obsolescenza tecnologica.
Qualcosa che vada oltre il pixel.
Più mi guardo e più mi rendo conto di andare in retromarcia, quasi scappando dall’evoluzione della società, che sempre meno riesco a seguire e dalle cui interferenze mi rendo conto sono spesso involontariamente condizionato. E mi ritrovo sempre più, fisicamente intendo, in ritirata. Se mi staccassi dal corpo e potessi osservare le mie abitudini, i comportamenti, le tendenze di spirito e del subconscio, beh, senza alcun dubbio vedrei una persona che anno dopo anno si sta ritirando e nascondendo nelle montagne. Non quelle note, battute, turistiche, ma i boschi, le alte vette, le gole rocciose, a Casanova, dove un tempo c’era anche un convento ma che oggi, invece, il “Leone” abita solitario. Vago in questi luoghi cercando la solitudine come ancora di salvezza, come aria pulita oltre una coltre padana di nebbia inquinata, come unica via per schermarmi dal rumore bianco della società umana.
La notte scorsa scendevo piano, l’aria era gelida, il vento non forte ti tagliava però a metà, ti svegliava dal torpore mentale accumulato nella quotidianità. Scendevo piano, finestrino semiaperto per approfittare di quella vista e di quel clima quasi perfetto (per me) a fare andare la fantasia e i sogni e, perché no?, anche le utopie. Utopie che ho rincorso e che adesso mi fanno sorridere e anche un po’ incazzare…
Scendevo e sorridevo, respiravo piano, rilassato, profondamente, perché già sapevo che non ne avrei avuto abbastanza e cercavo a tutti i costi di prendere tutto quello che si poteva prendere quella sera, anche rubandone un po’.
Scendevo lento, sereno e dietro ad una curva, così preso, improvvisamente vedo un animale sul ciglio pendente della strada. Immediatamente il mio cervello crea la visione e l’idea di un capriolo, avvistamento così comune la notte per quelle strade. Tutto ciò dura una frazione di secondo e la frazione dopo, invece, capisco che in realtà quello che sto osservando è un lupo. Era la prima volta nella mia vita. Resto immobilizzato, non dalla paura, anzi, ma da un’esplosione interna di emozioni; un calore che sale improvviso e inaspettato. Rallento fino a fermarmi con la macchina. Il lupo era grande, o così la mia emozione me lo faceva vedere; ma no era davvero grande. Lo osservo, un piccolo brivido di paura si fa spazio in me quando il lupo si gira nella mia direzione, si avvicina con sicurezza alla macchina e mi passa di fianco. Sono rimasto fermo per un tempo indefinito, probabilmente pochi lunghi secondi, e quella cosa che avrei voluto rubare quella notte, quell’ingordigia di emozioni e sensazioni me la sono portata via.
Naatsiiat è una parola groenlandese che letteralmente significa “qualcosa per cui uno aspetta molto tempo affinché cresca” e che poi è il termine groenlandese per patata. Riuscite a capire, a coglierne la forza distruttiva? Una visione prospettica completamente nuova, la relazione tra i groenlandesi e la vita. Che distrugge la nostra certezza occidentale, appunto.
Il tempo, il ritmo non imposto, l’abbandonarsi con accettazione alla volontà naturale. Accettare una prospettiva futura che non vada oltre qualche giorno, se va bene ed è estate, perché invece in inverno l’abbandono è totale e la quotidianità è dettata dalle volontà del vento, del ghiaccio e della neve.
Questa si chiama ispirazione per me. Per la mia fotografia.
Aputsiaq (“fiocco di neve”)